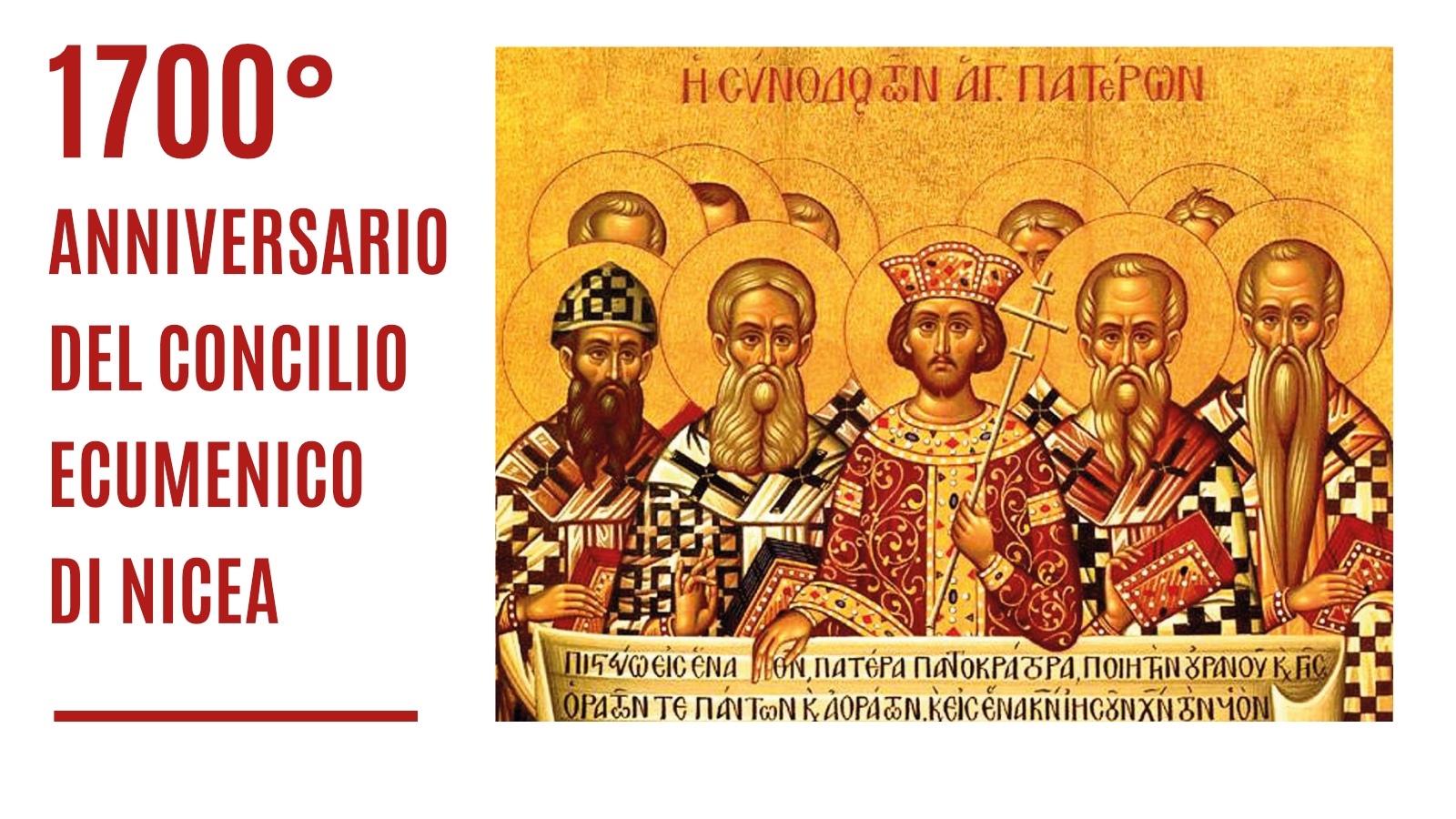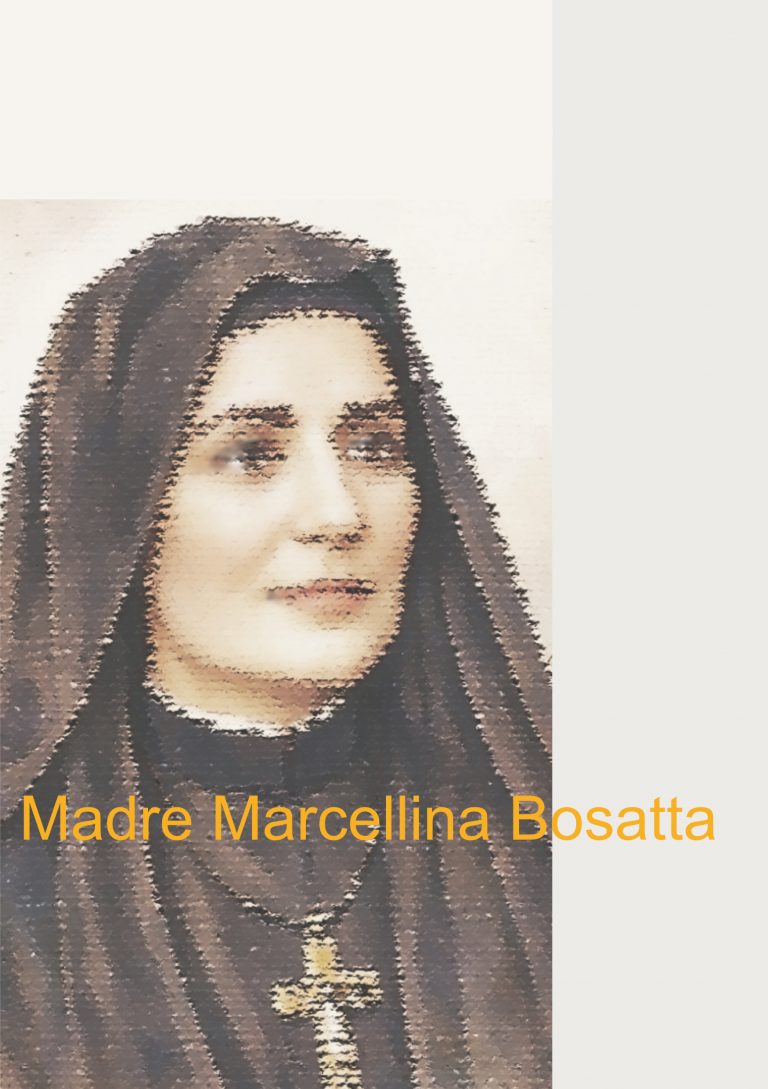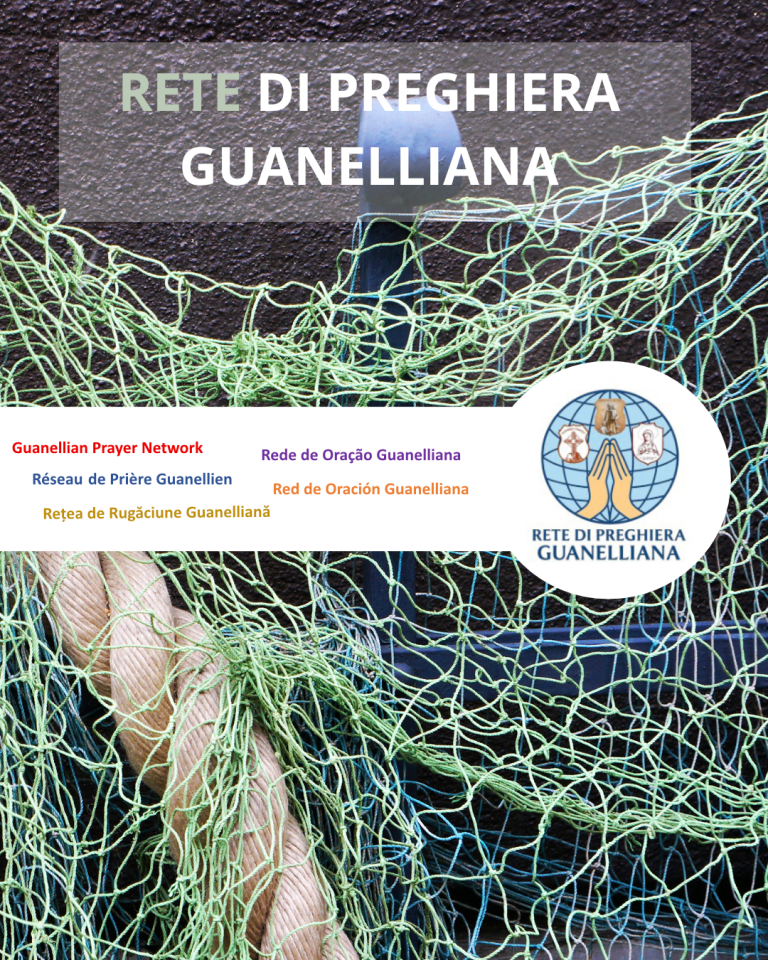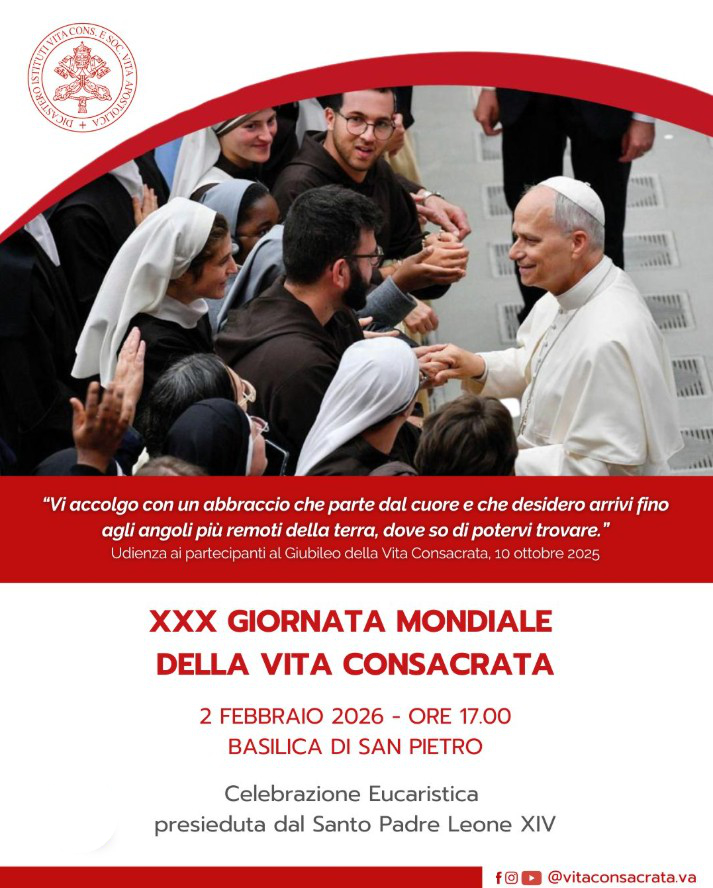L’eredità del Concilio di Nicea 1700 anni dopo
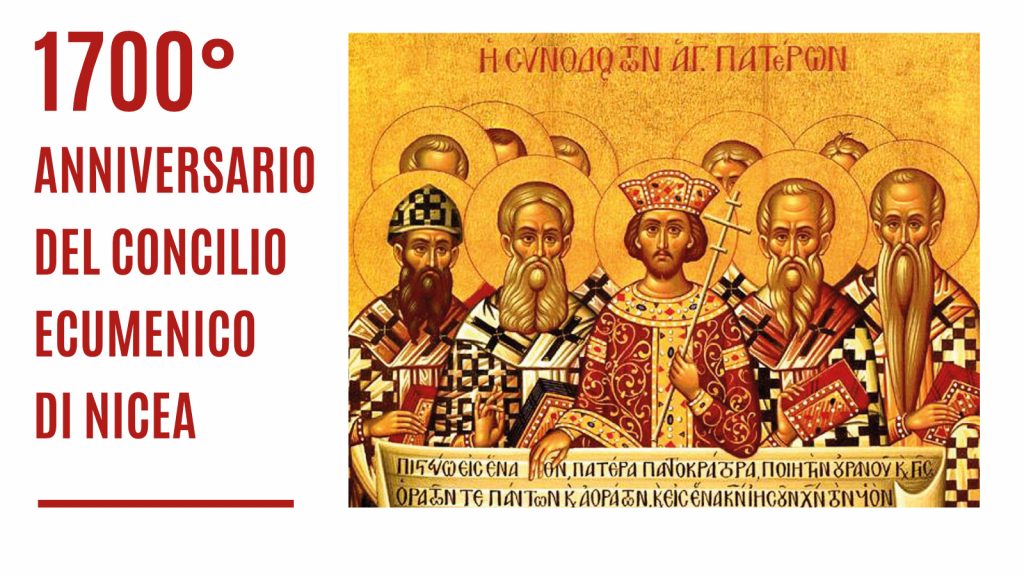
Concilio di Nicea (325 d.C.) ci ha lasciato il fondamento della nostra fede: il Credo. Ma cosa c’entra un documento di 1700 anni fa con la nostra vita quotidiana, le nostre paure e le nostre speranze? Ecco come le verità eterne si traducono in impegni pratici per noi cristiani.

A cura di suor Maria Teresa Nocella, guanelliana
La professione di fede promulgata dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. costituisce la pietra angolare della cristologia e possiede un valore che trascende la mera definizione dottrinale. La sua affermazione cardine – che Gesù Cristo è Figlio di Dio, “della stessa sostanza (homooúsios) del Padre” – non rappresenta un’arida formula teologica, bensì una notizia rivoluzionaria che ridefinisce radicalmente il rapporto tra Dio e l’umanità.
Nicea nacque come risposta all’arianesimo, una dottrina che collocava Cristo in una posizione intermedia: non Dio, ma neppure semplice creatura. I Padri conciliari, respingendo tale tesi, scongiurarono il pericolo di una fede basata su un Dio astratto o comunque irraggiungibile. L’affermazione della piena divinità di Cristo (l’unità di sostanza con il Padre) ha il potere di abbattere le barriere concettuali tra il Creatore e la creatura. In Gesù, Dio non è una “potenza” lontana, ma si è fatto nostro prossimo. La sua grandezza si manifesta non nella distanza, ma nell’atto di estrema umiltà descritto da San Paolo: Egli “svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo” (Fil 2,7). Questo movimento di discesa (descendit) rende la divinità accessibile all’esperienza umana.
Il vero scopo di questa unione sostanziale (l’Incarnazione) è la salvezza, o soteriologia. Se Cristo non fosse pienamente Dio, non avrebbe potuto sconfiggere la morte in modo definitivo né elevare la natura umana.
Come afferma la tradizione patristica, e in particolare Sant’Atanasio, il principio è chiaro: “Da Dio che era divenne uomo per poterci divinizzare”. Questo concetto non implica un’auto-deificazione umana, ma la partecipazione gratuita (per grazia) alla vita divina. Il nostro destino, in Cristo, è la piena umanizzazione e la partecipazione alla vita divina stessa, un superamento della caduta e un ripristino della dignità originaria.
Il Credo di Nicea, dunque, non è un monologo metafisico, ma un invito all’azione. La fede nel Dio che si è fatto prossimo esige un impegno quotidiano e un rovesciamento della prospettiva:
Il credente deve superare la tentazione di relegare Dio a una dimensione puramente spirituale o cultuale. L’unica via per incontrare il Signore che si è fatto servo è riconoscerlo nella nostra realtà e, soprattutto, nei nostri fratelli.
L’atto teologico di Nicea impone quindi un dovere etico-esistenziale: vedere in ogni prossimo, specialmente nel bisognoso, il volto del Figlio che per noi si è spogliato della sua maestà. In questo senso, la verità definita 1700 anni fa è la base della nostra vita cristiana.